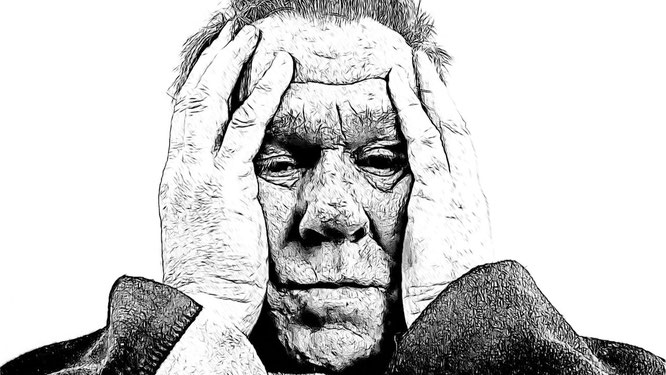
di Michela Cerimele
Siamo appena agli albori di una crisi economica devastante, che esige ora più che mai l’esercizio di un punto di vista di parte, dalla parte del lavoro. Il conflitto c’è ed è agito dall’alto.
Un nuovo prevedibile giro di vite sul lavoro è già in atto. È solo col conflitto che si può rispondere, unendo forze e intelligenze.
Con lo stato d’emergenza innescato dalla pandemia, sembra essersi scalfita la cortina fumogena che dai primi anni Ottanta del secolo scorso si è abbattuta sulla classe operaia, e sul mondo del lavoro tutto, determinandone “la fine” come soggetto sociale e politico. Nei mesi trascorsi abbiamo scoperto una verità cristallina eppure non scontata. Ossia che, se sostanzialmente scomparso dai radar delle narrazioni, delle analisi, del dibattito politico, il lavoro produttivo, non produttivo, di riproduzione non ha certamente cessato di esistere. Non lo si dirà mai abbastanza.
Nella prima fase del lockdown, è stato il lavoro di milioni di donne e uomini a tenere in piedi senza garanzie di sicurezza il paese, consentendo a una parte della popolazione di tutelare salute e soddisfare bisogni al sicuro delle proprie case. E per decreto abbiamo scoperto essere “essenziali” categorie di lavoro malpagate, svilite, spesso precarizzate e oltraggiate, da un quarantennio di attacco al lavoro senza quartiere. Operatrici e operatori della sanità, dei servizi collettivi e personali, delle pulizie, del trasporto, della raccolta dei rifiuti, del commercio, del settore agricolo, nonché schiere di operai nell’industria grande e piccola e nella logistica, solo per nominarne alcuni. Un intero mondo negato, con una forte presenza, in alcuni settori, di immigrati e con il lavoro femminile costretto nel tritacarne, potenziato dal lockdown, del doppio carico.
Il lavoro più vulnerabile e precario si è anche visto esposto per primo alla mera espulsione, in una situazione di assenza o inadeguatezza di ammortizzatori. Medesima la condizione del lavoro autonomo o cosiddetto tale. E poi ci sono gli informali, invisibili prima e dopo, forza lavoro straniera ma anche italiana. Si è pure avuto il coraggio di discettare sull’opportunità di applicare misure – insufficienti e discutibili – volte a consentire la temporanea emersione di alcuni.
Se sui tempi di ripresa dall’emergenza sanitaria non può che esservi il massimo dell’incertezza, non vi è dubbio che siamo appena agli albori di una crisi economica devastante, rispetto alla quale appare quanto mai urgente esercitare un punto di vista autonomo e squisitamente di parte, dalla parte del lavoro. Siamo infatti arrivati all’emergenza in corso da quarant’anni di neoliberalismo, passaggio di fase nell’organizzazione capitalistica configuratosi come sistematica lotta di classe dall’alto, con il punto di vista del capitale divenuto unico punto di vista legittimo, sul lavoro e sulla società tutta. Come quelle precedenti, la crisi innescata dal Covid è destinata a provocare una riedizione, in versione ancor più brutale, della logica-principe che ha guidato gli ultimi decenni. Logica che ha normalizzato il perseguimento di profitti e rendite come variabile indipendente da tutto, da ogni idea di diritto al lavoro e sul lavoro, persino dai limiti che la stessa riproduzione della vita impone.
Senza voler mettere in conto il ruolo giocato dei padroni nella diffusione del contagio – non dimenticheremo le mancate zone rosse in Lombardia – paradigmatiche sono state le esternazioni di Confindustria delle ultime settimane, per voce del suo neo-presidente Carlo Bonomi e del suo vice Maurizio Stirpe. Lavoratori accusati d’irresponsabilità per aver scioperato. Rivendicavano un diritto basilare, quello alla sicurezza, e per questo motivo più di qualcuno il posto di lavoro se l’è pure giocato. Lavoratori che si vuole fuori dai contratti collettivi. Una “vecchia, vecchissima, idea”, ha osservato correttamente Simone Fana su Jacobin Italia (5 maggio), per avere mani libere su salari, produttività e organizzazione del lavoro. Niet alla riduzione degli orari a parità di salario. Richiesta immediata di tagliare l’IRAP (che finanzia servizi come la sanità regionale) anche per le aziende che hanno continuato a fatturare durante l’emergenza. Richiesta tanto martellante quanto inaccettabile di uno “scudo penale” per le imprese, in una fase in cui il rischio di contagio è altissimo. E, soprattutto, una non nascosta mira ad accaparrarsi il grosso delle risorse economiche disponibili; e una non nascosta irritazione per tutto quel che è sostegno al lavoro e, più in generale, a chi pagherà e sta già pagando la crisi. Esempio da manuale di una lotta prolungata di chi sta sopra contro chi sta sotto. Ha fatto bene Marta Fana a definire le parole di Bonomi (intervista del 4 maggio, Corriere della Sera) un “insulto ai lavoratori”, quelli che hanno continuato a lavorare e quelli rimasti senza un’occupazione.
Secondo l’OIL, a livello mondo, 1,25 miliardi di lavoratrici e lavoratori sono a rischio di perdita di occupazione. Nella nostra Italia, con la Fase 2 in molti non sono tornati al lavoro, e non abbiamo ancora dinanzi un’ecatombe simile a quella degli Stati Uniti solo grazie al blocco dei licenziamenti e alla cassa integrazione. Per altrettanti – coloro i quali al lavoro vi sono sempre stati, quelli rientrati, quelli che vi rientreranno – le condizioni sono peggiorate o peggioreranno. Racconti e denunce, poco esplorati, ma ben presenti in rete, suggeriscono che un nuovo prevedibile giro di vite è già in atto. D’altro canto, la disoccupazione strutturale che ha connotato l’ultimo quarantennio ha rappresentato la più fertile delle condizioni per rendere socialmente accettabile lo scambio tra accesso al lavoro e diritti sul lavoro. Con l’aggravante che, per tutti coloro i quali per vivere devono lavorare, e un lavoro ce l’hanno, il rischio anche in termini di sicurezza e salute ora si fa altissimo.
In uno scenario così, sembrano utili alcuni punti di riflessione.
Quello della coesione sociale è un vecchio refrain che ha ripetutamente mascherato negli ultimi decenni lo scaricamento dei costi delle crisi sul lavoro e sui più deboli, contribuendo a sopire il conflitto a vantaggio di una parte sola. Di fatto il conflitto, inteso come organizzazione e avanzamento delle istanze e degli interessi di una parte, è già agito dall’alto. Ed è col conflitto, storicamente unico vero motore del cambiamento, che bisognerà rispondere.
La centralità del lavoro nella relazione sociale capitalistica ne fa tutt’oggi, almeno in potenza, un imprescindibile soggetto di trasformazione, che necessita chiaramente di un raccordo sia al suo interno che con i movimenti e le lotte agite ad altri livelli. Si dà tuttavia la necessità di superare la narrazione divisiva che ha accompagnato la moltiplicazione delle forme contrattuali negli ultimi decenni; dispositivo potentissimo, quest’ultimo, in grado di abbassare i costi del lavoro, intensificarne lo sfruttamento e disciplinarlo simultaneamente. Basti pensare a come il tema della “dualità del mercato del lavoro”, centrale nel discorso neoliberale, sia tutto giocato sul teorema per cui la piaga del precariato o dello stesso non-lavoro è da ricondursi ai “privilegi” dei “garantiti” (quelli con qualche diritto), non già all’attuale configurazione del capitalismo. La soluzione ovvia è di abbattere ovunque i diritti sul lavoro, cancellando ogni appiglio rivendicativo con l’obiettivo, forse, di fare delle forme del lavoro migrante – per eccellenza disponibile e adattabile – la frontiera da generalizzare.
I venti freddi della crisi cui siamo esposti rischiano di nutrire ulteriormente gli antagonismi interni alle forze del lavoro stesse, tra chi è dentro e chi è fuori, chi è più garantito e chi lo è meno, tra giovani e meno giovani, italiani e stranieri. Solo l’adozione di un punto di vista di parte sul piano dell’analisi e dell’azione potrà consentire di cogliere l’esistenza, pur nella diversità, di un denominatore comune tra i diversi regimi di lavoro in essere e tra questi e il non lavoro, tramutando gli antagonismi interni in solidarietà e indirizzando il conflitto là dove deve essere indirizzato.
Un nuovo Statuto dei lavoratori adeguato a un mondo del lavoro profondamente mutato è a nostro giudizio necessario: gli interventi legislativi degli ultimi decenni hanno ferocemente sottratto diritti, dignità e capacità di organizzazione alla nostra parte. Allo stesso tempo, come ricorda Sergio Bologna dalle pagine de “il manifesto” (21 maggio), le leggi non fanno che riflettere “i rapporti di forza vigenti tra le classi”, ed è su quei rapporti di forza che è fondamentale agire, per andare oltre. È necessario al riguardo (ri)portare il lavoro, nelle sue molteplici espressioni, al centro dei nostri percorsi di ricerca e azione. Provando a stare ovunque il conflitto sta, in potenza o di fatto, supportandolo, facendolo emergere e cucendo alleanze dentro e fuori i circuiti della sindacalizzazione classica. Con a mente, da un lato, la collocazione del lavoro e del conflitto stesso lungo le catene globali della produzione; dall’altro, la prevedibile riorganizzazione della produzione e intensificazione del lavoro tramite le tecnologie digitali. In questo senso, sembra fondamentale accogliere richiami come quello venuto di recente dal “Manifesto di Officina Primo Maggio”, che lancia un vero progetto politico-culturale di parte e collettivo volto a esplorare la mutata natura del lavoro capitalistico e le “condizioni che rendono praticabile il conflitto”. Per dare una risposta all’altezza della fase – fase che vede la ferocia del nostro avversario dispiegata al massimo – noi per primi, realtà e singoli/e, non possiamo che provare a unire intelligenze e forze.
Tratto da:

